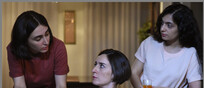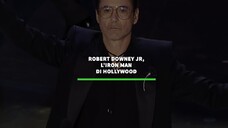Ognuno la fa diversa. Ma le
'capitali' sarde della panade sono ben suddivise tra sud, centro
e nord: Assemini, Cuglieri e Oschiri. Un piatto tipico isolano.
Ma con molti "cugini" nel resto del mondo, soprattutto in
Spagna. E con molte testimonianze di qualcosa di simile già dai
tempi dell'Inquisizione: l'approdo in Sardegna della "torta"
ripiena di carne, di anguille o di ortaggi si deve agli ebrei in
fuga dalle persecuzioni. Un tema molto gustoso affrontato a
Cagliari durante uno degli appuntamenti della VII edizione del
Festival Premio Emilio Lussu.
Alcuni aspetti sono stati ricordati nel viaggio di "Panada on
the road", opera dell'antropologa e scrittrice Veronica Matta.
Madrid, Palma di Maiorca e Minorca sono parenti strette di
Cuglieri, Assemini e Oschiri. In Spagna c'è anche il singolare
culto della Madonna della panada: proprio a Palma di Maiorca è
stata infatti realizzata una statua della Vergine che tiene in
braccio il Bambin Gesù. E che nella mano destra sorregge una
piccola panada. Ne ha parlato padre Miquel Mascarò, custode del
Santuario Hermita de Sant Honorat a Randa e caballero de Santa
Maria de la Panada. L'arrivo della panada in Sardegna è stato
invece rievocato dallo studioso ebraico Pinhás Ben Abrahamle,
secondo il quale la panada era un piatto che poteva consentire
una certa continuità nelle abitudini alimentari, permettendo di
nascondere all'interno, come in uno scrigno, sia il cibo che
l'utilizzo di determinate spezie che la tradizione cristiana
preferiva evitare.
Un piatto alla fine insieme internazionale e locale con
radici antiche, ma che poi viene personalizzato e tipicizzato.
Il concetto di panada, hanno spiegato gli esperti, non è legato
in particolare a una ricetta, quanto al metodo culinario e di
conservazione del cibo all'interno della pasta di farina o di
semola, che troviamo in tutto il mondo anche se sotto un nome
diverso.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA